
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more (If It Be Your Will by Leonard Cohen)
Com’è difficile lasciarli andare, abbandonarsi al dolore della perdita. Come si può lasciare andare una parte di noi? Sarebbe come separarsi da un arto, da un organo senza il quale non si può vivere. Il dolore è talmente forte e radicato che esplode dentro e, a volte, ossimoricamente, più la lacerazione è profonda e meno lascia i suoi segni sulla superficie; così ci si affeziona anche alla sofferenza, perché colma il senso di vuoto, perché materializza la mancanza. Quel dolore lacerante diventa quotidiano e non si è in grado di separarsene; non si può, è funzionale alla vita, aiuta ad andare avanti; è una corazza, è quella spina ben conficcata nella carne sanguinante che fa sentire vivi e rende sempre presente il ricordo. L’amato rimane con noi grazie al dolore che la sua perdita procura, e non si può dimenticare.
L’angoscia assume una consistenza fantasmica, una necessaria presenza priva di corpo, ma il desiderio, la passione, il bisogno di non sentirsi abbandonati le danno forma e materia. L’urgenza della vicinanza deraglia verso l’illusione pur di salvarsi dalla follia, dalla certezza, forse, di una debolezza che spinge sull’orlo del baratro, preferendo la morte alla vita, perché meno dolorosa, in una resa che non ammette perdono.
Gli occhi di un bambino vedono oltre, gridano no alla morte, si cullano nell’inganno, spingendosi nel non visto e nel non visibile, proiettando il bisogno di amore nel dolore; lo chiudono in una bara vuota, lo plasmano nella figura vigile, severa e apotropaica di un personaggio televisivo, il fantasma Belfagor.
Come over to the window my little darling,
I’d like to try to read your palm.
I used to think I was some kind of Gypsy boy
before I let you take me home.
Now so long, Marianne, it’s time that we began
to laugh and cry and cry and laugh about it all again. (So long, Marianne - Leonard Cohen)
Una donna velata di nero, il volto nascosto da una maschera che ne cela la reale identità, una presenza a metà strada tra la vita e la morte, un fantasma che risiede in una zona di non vita, che veglia sul piccolo Massimo. La forma che assume il dolore di un bambino risiede nel quotidiano irreale filtrato dal tubo catodico che alimenta gli incubi, le paure ma allo stesso tempo i desideri, il bisogno di essere amato da quella figura materna che lo ha abbandonato. A volte non si vede, altre volte si sceglie di non voler vedere. Gli indizi ci sono, la realtà è lampante, ma lo sguardo decide di perdersi volontariamente in uno smarrimento terapeutico. Chiudere gli occhi e rifugiarsi in una tenera bugia, mentire a se stessi per proteggersi dalla vita; una mistificazione illusoria perché il dolore, pur rimanendo presente, non ci trovi poi così facilmente, giocando a nascondino tra le emozioni, tra le zone d’ombre.
Ogni immagine è virtuale, sospesa tra il reale e la sua astrazione. La realtà viaggia su due binari che scorrono in parallelo, l’uno sull’altro. A volte i piani collimano, altre volte si estraniano l’uno dall’altro. Massimo è teso, sempre rivolto in un angolo tra due muri, con i palmi delle mani rivolte davanti a lui, per difendersi, per non essere toccato. Emozioni, sentimenti e paura sono tenuti distanti. Chiuso in un guscio inscalfibile, è granitico nei confronti della vita, vive di “se” nella sospensione di un tempo che non ammette vie d’uscita, si rivolge alla fede solo come soluzione al suo dolore, nella vana speranza che gli renda indietro ciò che gli è stato tolto senza spiegazione.
Un ultimo bacio è un bacio negato, privo di ricordo, non vissuto, perché il sonno rapisce la mente e il corpo stanco, il calore e l’affetto materno si perdono in una notte d’inverno, mentre la neve scende lenta, avvolgendo ogni cosa nel suo silenzioso manto soporifero, ovattando il fragore della perdita, nascondendo il dolore della morte.
La gioiosa follia di una mamma bambina, che ritaglia le foto delle stelle del momento, custodendo i sogni di carta in un album dalle pagine scure, ora balena come una scintilla negli occhi velati dalle lacrime del male di vivere, ora si accende rumorosa, scatenandosi in un twist con il suo bambino, o cantando le canzoni di Modugno; un canto disperato, forse una richiesta d’aiuto rivolta proprio al suo piccolo, ignaro di tutta quella sofferenza, ma innamorato della sua mamma.
Uno sguardo perso nel finestrino di un bus, smarrito tra i deliri di pezzi alla deriva che difficilmente ricompongono un animo così fragile, in un precario equilibrio fanciullesco; parafrasando Carmelo Bene in Nostra signora dei Turchi, “lei stava in equilibrio, come un filo del ventre premuto al davanzale, i piedi in aria, mentre lui le cercava il palazzo moresco tra i capelli, spettinando le cupole e le arcate dipinte appena dalla luna fresca, quando i rossi grattati parevano lentiggini sulla pelle più bianca delle cupole, all'illusione”.
Nell’arco di trent’anni, la storia scorre in parallelo alla crescita di Massimo; le immagini filtrate dalla tv regalano uno spaccato degli ultimi anni dell’Italia delle canzonette della Carrà, fino a Mani pulite, con Di Pietro sullo sfondo e l’attacco per analogia con la figura di Giovanni Athos, che tanto ricorda il Raoul Gardini di quegli anni.
Da bambino dissidente e rancoroso, Massimo diventa uomo, subisce la vita, quasi inerme, in maniera remissiva. La guerra a Sarajevo con le sue nefandezze e le scelleratezze del genere umano che si miscelano alle tante atrocità; liberarsi dei ricordi in quella casa in cui è cresciuto insieme al suo dolore diventa un’esigenza, buia, piena di ombre e dall’atmosfera claustrofobica, vicina, per alcuni aspetti, alla casa de I pugni in tasca. Massimo vuole voltare pagina, tagliare con gli austeri busti di Napoleone, con Juliette Greco e Belfagor, allontanarsi per sempre da quelle pareti che trasudano sofferenza, impregnati di lacrime. Nessuna donna potrà mai sostituire la figura di sua madre, come in quel Cat People le cui immagini scorrono sullo schermo quando da piccolo cerca il profumo della mamma tra le braccia di un’estranea; nessuna donna può sostituirsi ad un’altra, ogni donna è unica, nelle sue fragilità, nella sua capacità di dare amore e anche nell’impossibilità di tollerare il dolore quotidiano di vivere.
È forse la presa di coscienza del suicidio della madre che libera Massimo dal fardello di quella sofferenza, o almeno da una parte di essa, perché “è più coraggioso crescere un bambino che arrendersi alla morte”; la resa da parte dell’oggetto della sua passione è per lui inconcepibile, e in qualche modo gli infonderà il coraggio di (ri)prendere a vivere.
In Fai bei sogni, dal libro di Massimo Gramellini, ci sono tanti temi cari a Marco Bellocchio, dalla figura materna, alla famiglia, alla morte che aleggia lungo tutto lo scorrere del film, presenza ingombrante ma voluta e desiderata. In quest’ultima opera di Bellocchio, presentata a Cannes 69 alla Quinzaine des Réalisateurs, c’è soprattutto la poetica di un Autore che, se nel precedente Sangue del mio sangue si affidava ad una narrazione anarcoide, conferendo all’opera una libertà visionaria e surreale, qui si inspessisce di sentimenti laceranti, emozioni vere che arrivano come fendenti al cuore dello spettatore. Nonostante il tema trattato, Bellocchio non indulge in scontati sentimentalismi ed eccessi buonisti, ma tratteggia in maniera oggettiva ed eticamente neutrale le vicende e i suoi protagonisti.
Una mise en scène deliziosamente retrò, grazie anche alla fotografia di Daniele Ciprì, saldamente legata a un logos che parla direttamente all’anima, una contorsione dei sensi che graffia il cuore, con dolore.
C’è una strada che una madre e suo figlio dovrebbero percorrere insieme, vicini l’una all’altro, un tragitto che accompagna entrambi nella crescita, un percorso che seppur breve non deve essere turbato, perché il cordone ombelicale li rende un corpo unico, un mondo unico, un universo a parte. Così dovrebbe essere.
Mariangela Sansone
Sezione di riferimento: Film al cinema
Scheda tecnica
Titolo originale: Fai bei sogni
Anno: 2016
Regia: Marco Bellocchio
Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Valia Santella, Edoardo Albinati
Interpreti principali: Valerio Mastandrea, Berenice Bejo, Roberto Herlitzka. Guido Caprino, Fabrizio Gifuni
Fotografia: Daniele Ciprì
Musiche: Carlo Crivelli
Durata: 137’
Uscita italiana: 10 novembre 2016






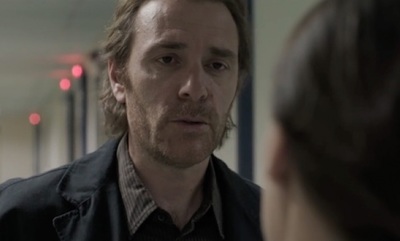


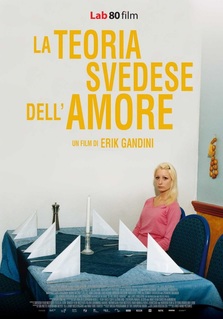

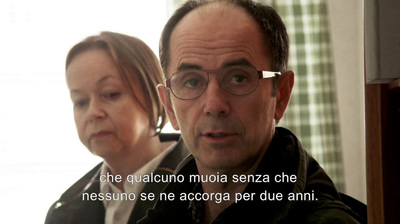

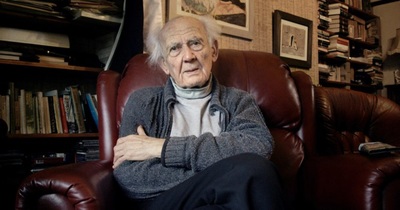
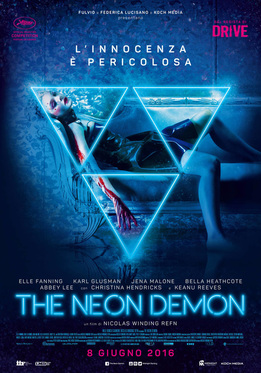
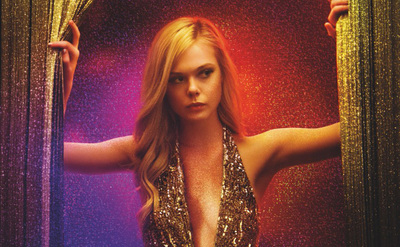



































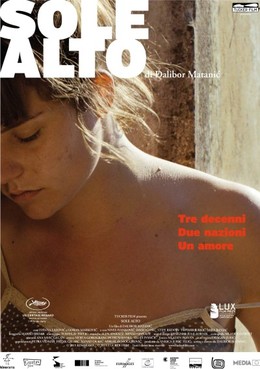




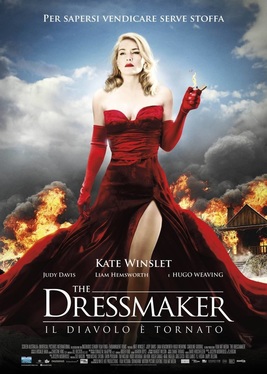








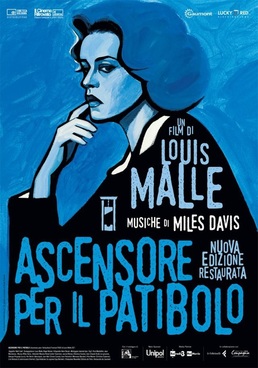









 Feed RSS
Feed RSS
