
Gene Tierney è un’attrice “per pochi”, suo malgrado. Con i chiarissimi occhi a mandorla sempre pronti a scivolare verso l’inverno, gli zigomi alti e la figura esile appare sullo schermo come una dea silenziosa. Non fa rumore. Quando parlo di attrici del passato basta citare alcuni nomi per vedere entusiasmo sul viso del mio interlocutore: Bette Davis, Rita Hayworth, Katharine Hepburn, le indimenticabili. E poi faccio un goffo tentativo, dico “Mi piace molto anche Gene Tierney” e dall’altra parte vedo spesso uno scomodo punto interrogativo.
Chi è Gene Tierney?
Il cielo può attendere di Ernst Lubitsch è il primo lavoro in Technicolor del regista, uno splendido abuso di colore che di colpo inonda le gonne e gli occhi, le tende e le camere da letto. Un'opera sofisticata che sfugge un po’ alle sembianze di commedia romantica esplosiva alle quali Lubitsch ci ha educati, recuperata da Lab 80 nell’intento di raccontare la Tierney in quattro titoli restaurati, da oggi disponibili in sala: oltre a Heaven Can Wait anche Il fantasma e la signora Muir di Mankiewicz, Vertigine di Preminger e Femmina folle di Sthal. Una bellissima iniziativa, che rappresenta il rilancio della distribuzione dei classici per Lab 80 film; una rassegna deliziosa come il sorriso ultraterreno della grande attrice che in pochi ricordano; una missione coraggiosa che porta ai nostri occhi questo cielo in attesa, con i suoi colori fiammeggianti.
Il racconto ha inizio niente meno che all’inferno, elegante palazzo dove il “direttore” riceve uno dei nuovi “candidati all’ingresso”. Si tratta di Henry Van Cleve (un irresistibile Don Ameche), settantenne dalle battute di spirito taglienti, con una vita da impenitente Casanova sulle spalle. Quando il diavolo gli chiede perché mai si sia presentato al suo cospetto, Van Cleve si rimbocca le maniche e ci guida attraverso un lungo flashback alla ricerca di quel “motivo valido per meritarsi l’inferno”.
Coccolati dall’atmosfera surreale e spiritosa, seguiamo la narrazione delle gesta di Van Cleve sin dalla culla: potremmo quasi definirlo un atipico e allegro barone di Münchhausen, che giunto alla fine dei suoi giorni sente il bisogno di alleggerire la coscienza di certi antichi pesi. Bambino terribile, giovane scapestrato, giocatore d’azzardo, pecora nera della famiglia (dove si distingue un impagabile Charles Coburn nel ruolo del nonno) e celebre Dongiovanni, l’unica occasione che gli si presenta per rimettere la testa a posto è l’incontro con Martha Strable.
Quest’ultima è la promessa sposa del cugino, ma per Van Cleve non sarà arduo spingerla fra le proprie braccia. A impersonare la timida sposina arrivata dal Kansas c’è proprio la Tierney e su di lei ci fermiamo un istante. Per sospirare, per catturare con gli occhi i preziosi colori del suo piumaggio. Nella scena del ricevimento prima delle nozze la Tierney indossa un vaporoso abito celeste che oggi abbiamo la possibilità di vedere nitido in ogni dettaglio grazie al restauro. L’attrice ingaggia una gara di freschezza con il fiore rosa tenue che tiene fra i capelli: ogni primo piano fa arrestare i battiti per la bellezza pura e splendente di quel viso, la luminosità dei capelli sapientemente acconciati, i bagliori glaciali degli occhi dal taglio quasi orientale.
Quel fiore accomodato fra le ciocche non fa che esaltare l’incredibile fascino del viso di Martha. Uno starnuto della giovane sposina diviene l’occasione per restare sola con Van Cleve; ha inizio così quella che a tutti gli effetti ci sembrerà una storia d’amore, pur lasciando in noi una sottile, perenne amarezza.
Questa commedia di schermaglie amorose e fughe passionali, di battute caustiche e siparietti gustosi, è un’accurata immersione in cui si scrutano fondali più vasti. La morte ha quasi un posto d’onore, nel film; la fiutiamo onnipresente nelle scene per quanto i colori e le risate vorrebbero convincerci del contrario. Fa tenerezza l’imperdonabile Van Cleve con le sue scappatelle, eppure è Martha la portatrice di un messaggio più profondo. Sta a questa Gene Tierney, alle prese con una delle sue più impegnative prove cinematografiche, riassumere l’amore e le sue tempeste, la rassegnazione e la pazienza. Non soltanto commedia, perciò, ma racconto intimo di un amore difficile.
Raccogliamo con cura questi frammenti della Diva Fragile che Lab 80 oggi ci regala. Perché non esiste una sola risposta alla domanda “Chi è Gene Tierney?”.
È stata un’attrice elegante, fresca come un fiore eppure perseguitata da sventure e periodi depressivi sfociati in terapie di elettroshock; è stata un sorriso con la notte sul fondo; è stata una voce troppo sottile ingrossata con il fumo di sigarette nella speranza di sembrare più fatale.
Per chi l’ha amata come me è stata la misteriosa Laura di Preminger, la perfida e disumana Ellen di Stahl, la dolcissima e agguerrita Lucy di Mankiewicz, presenza delicata in una casa dei fantasmi. E la Martha Strable che ama irragionevolmente un Henry Van Cleve, la donna che attende in quel cielo che può attendere e che finalmente torna al cinema.
Maria Silvia Avanzato
Sezioni di riferimento: Film al cinema, Vintage Collection
Scheda tecnica
Titolo originale: Heaven Can Wait
Anno: 1943
Durata: 112'
Regia: Ernst Lubitsch
Soggetto: dal lavoro teatrale Birthday di Leslie Bush-Fekete
Sceneggiatura: Samson Raphaelson
Fotografia: Edward Cronjager
Musiche: Alfred Newman
Attori: Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn, Louis Calhern, Spring Byington




























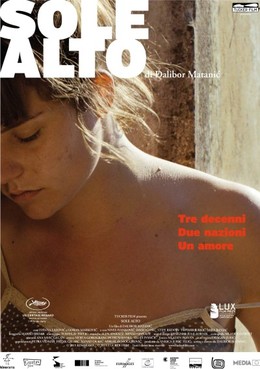









 Feed RSS
Feed RSS
