
L’onestà su cui si gioca il valore di una recensione ci impone di ammettere lo stato d’animo con cui si è entrati in sala: una diffidenza non troppo rigida, sufficientemente disposta a ripensamenti da scongiurare l’eventualità di sorprese troppo clamorose (stordente per il critico). Si sospettava di veder sciorinata la zolfa retorica a lungo rimasticata, un racconto tirato su fra citazioni e umori nostalgici, la fiaba seriosa di un’antica solidarietà bucolico-comunista. Ma mentre già si argomentava solennemente la stroncatura, inizia un altro film.
Certamente Loach non fa a meno della tesi; in Jimmy's Hall la chiarezza è una necessità da cui non è esente nessun elemento della storia, dall’inquadratura descrittiva più semplice ai personaggi, e per fare chiarezza occorre schierare oppressi e oppressori confinandoli in opposte regioni di pensiero. Eppure a riscattare tutto intervengono prontamente l’ironia garbata e un sano distacco della regia dagli eventi, espedienti che da soli concorrono a suscitare nello spettatore non schierato sconcerto di fronte alle non poche prevaricazioni che i rivoltosi, ma fragilissimi, eroi di Loach subiscono, e rabbia, perché quello che Loach ci chiede non è tanto interrogare la storia nelle sue colpe e nelle possibilità negate alle sue vittime, ma riflettere sulle fondamenta umane di una rivolta, ragioni trasversali ai tempi e ai luoghi: l’amore per le proprie radici, la necessità della conoscenza, la ricerca della solidarietà.
Lontano anni luce dall’ambizione di raccontare ex cathedra la storia (ma altrettanto lontano dall’ambizione di reinventarla, a cui ci ha viziati fin troppo bene l’ultimo Tarantino), Loach filma con lo sguardo piantato nei confini della campagna irlandese, iniziando con un ritorno e finendo con un sofferto allontanamento. In mezzo, l’avventura di Jimmy Gralton (Barry Ward), esiliato in America nel 1921 perché, durante la guerra civile irlandese (che contrappose indipendentisti radicali e repubblicani favorevoli all’unione con la Gran Bretagna), aveva osato metter su una modesta sala da ballo, luogo di festa e condivisione, rendez-vous per i giovani della comunità dove volenterosi maestri insegnavano letteratura, musica, arte e naturalmente danza di gruppo. La Chiesa, dal suo alto scranno censorio, sola detentrice del potere di preporre usi e costumi di un popolo, tacciò Gralton di comunismo sovversivo provvedendo in fretta al suo esilio.
Dieci anni dopo, Gralton torna dall’America. La terra promessa, di cui ci viene raccontata come un monito la ricca stagione di lusso e speculazione, preludio al crollo del ‘29, è un luogo lontano, smarrito in sbiaditi materiali d’archivio (come quelli con cui si apre il film). Jimmy se ne porta dietro il simbolo tecnologico più progredito (il grammofono) con 78 giri di jazz. Spinto dalle pressioni delle nuove leve della comunità, ricostruisce la leggendaria sala, riportando vecchi e nuovi amici sulle tavole da ballo. Ma il parroco Sheridan (Jim Norton) medita di assumere il controllo sulla sala oppure di annientarla, conducendo una battaglia prima personale poi più estesa e violenta contro le barbare influenze di musica e costumi stranieri.
Saggiamente Loach affida al parroco il ruolo di antagonista sfumato, spregiudicato ma pensieroso, tremendo simbolo della resistenza del vecchio mondo oscurantista, ma anche uomo indeciso e capace di impreviste uscite autoironiche. Jimmy è fin troppo rigido, come uno schema alla lavagna: eroico, quindi d’azione, non di pensiero. È nelle velate incertezze di tono, nei bivi tra silenzi e lunghi dibattiti che il film guadagna i suoi momenti più riusciti, piuttosto che quando si affida a espedienti più semplici: uno su tutti il montaggio parallelo che contrappone le danze scomposte e vitali nella sala di Jimmy all’ambiente asettico e rigidamente bipartito della chiesa, dove Sheridan condanna Gralton e elenca i nomi dei partecipanti alla sua festa come da una lista di dannati.
Meglio il lento ballo sotto il pallore lunare tra Jimmy e l’amata (e perduta) Oonagh (Simone Kirby), nella sala vuota e con la musica sognata e poi dissolta, come dissolto è infine il sogno libertario, troppo breve e forte da far uscire il sangue dal naso, come cantava il piccolo indiano di Fiume Sand Creek.
Matteo Mele
Sezione di riferimento: Film al cinema
Scheda tecnica
Titolo originale: Jimmy’s Hall
Anno: 2014
Durata: 109’
Regia: Ken Loach
Interpreti: Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Andrew Scott, Francis Magee, Aisling Franciosi
Sceneggiatura: Paul Laverty
Musiche: George Fenton
Uscita italiana: 18 dicembre 2014





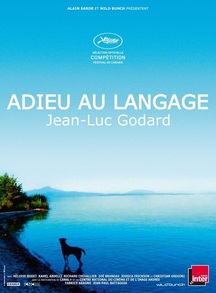

































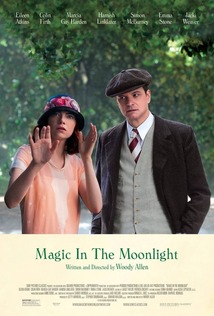














 Feed RSS
Feed RSS
