
Un paganesimo onnipresente ha logorato tutto, trasformando ogni angolo di realtà in un decadente quadro estetizzante e dando vita a un nuovo naturalismo di immagini che non hanno nulla di distensivo ma vivono soltanto delle loro radici inquietanti e misteriose. Proiettate, al limite, verso la materializzazione impossibile di una quinta fase dell’anno che mai arriverà ma che non potrà sottrarsi dal continuare a farsi incombente e minacciosa, oscillando come una maledizione simile a un peccato originale partecipato sull’universo nordico e fiammingo di Brosens & Woodworth. Non sono percorribili altre strade al di fuori dell’evidenziazione di tale colpa inespiabile, a riprova di una matrice intellettuale dell’approccio che parte da un immaginario fiabesco scandinavo ma se ne discosta ben presto, abdicando a tutto vantaggio della totale rarefazione.
Dopo aver girato Khadak in Mongolia e Altiplano in Perù, i registi portano a termine una loro ideale trilogia nel loro paese d’origine, il Belgio, ritratto con quell’irrinunciabile ascetismo che li ha portati a sondare i luoghi e gli angoli più remoti del pianeta senza fermarsi alla mera contemplazione degli spazi e degli ambienti ma piuttosto affiancando a essa un preciso discorso sul concetto di aggregazione umana e di spirito comunitario. Un elemento che diviene centrale nella loro ultima fatica, che alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia spaccò la ricezione degli addetti ai lavori nelle due proverbiali, opposte fazioni di scettici e infastiditi da un lato e di affascinati e irretiti dall’altro. Complice, forse, il particolarissimo nucleo umano di queste lande desolate che oscilla costantemente tra la stranezza e la peculiarità, contribuendo ad amplificare lo straniamento e il senso di astrusità respingente di un film che per lo spettatore comune e poco abituato a pochissime se non a nessuna forma di cinema ricercato e indagatore può risultare pressoché impenetrabile.
Nonostante questo limite sulla carta non da poco, La quinta stagione riesce però a conquistare e perfino a tratti ad avvincere col magnetismo delle sue proposte visive, coi suoi rimandi pittorici bruegeliani e la rappresentazione di una natura ibrida e violenta, la cui dannazione appare provenire perfino dagli angoli più sperduti e inviolati del cielo, generando un senso di oppressione (ir)respirabile in moltissime scene.
Certo, non manca l’ermetismo, reso palese attraverso un accumulo di interrogativi esistenziali e antropologici che appaiono come aporetici a priori né sono sviluppati nella loro completezza. La quinta stagione, dopotutto, è un film che si lascia soprattutto guardare, che non sembra avere o anelare ad altre urgenze al di fuori di quella, autosufficiente e già di per sé beatificante, di farsi materia di contemplazione. È un film non esplicativo in nessuno dei suoi momenti (e di attimi visivi notevoli, a ben guardare, ce ne sono tanti, si veda la scena del bacio iperrealistico e sboccato), allusivo per vocazione e per scelta etica, suggeritore costante di enigmi insoluti e di arditezze problematiche.
La scena iniziale col gallo è a suo modo un’immagine potente e indimenticabile, più vicina all’installazione che al cinema e proprio per questo motivo isolabile plasticamente nella memoria di chi la guarda. Un’operazione mentale che forse con la totalità dell’opera riesce molto più difficile, data la nebulosità che vi alberga, senza però rinunciare a squarci di ironia caustica a metà tra il brio e il veleno, sulla scia delle atmosfere di un altro autore nordico imprescindibile per il cinema moderno come Aki Kaurismaki, presenza innegabile nelle numerose scene corali e affollate e non solo in quelle.
Davide Eustachio Stanzione
Sezione di riferimento: Film al cinema
Scheda tecnica
Titolo originale: La cinquième saison
Anno: 2012
Regia: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Sceneggiatura: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Fotografia: Hans Bruch jr.
Montaggio: Jessica Woodworth
Costumi: Claudine Tychon
Musiche: Michel Schöpping
Durata: 93'
Attori: Sam Louwyck, Aurélia Poirier, Django Schrevens, Gill Vancompernolle






































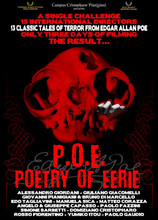




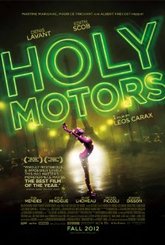






















 Feed RSS
Feed RSS
