
Ci sono film che nascono dall'idea di un un'unica persona, responsabile di tutto il processo creativo. Altri invece sono il risultato di una sorta di parto graduale e collettivo, alla fine del quale il risultato sullo schermo assomma sensazioni e personalità di ciascuno dei componenti. È il caso di Quello che non so di lei (D'après une histoire vrai), nuovo film di Roman Polanski, presentato lo scorso anno a Cannes e ora uscito, con molti mesi di ritardo, anche nei cinema italiani. Un lavoro stratificato, la cui base è un romanzo di Delphine de Vigan, consigliato a Polanski dalla compagna e musa Emmanuelle Seigner. Il libro d'origine è approdato nelle sale transitando dalla penna di Olivier Assayas, in veste di sceneggiatore, per essere infine (parzialmente) plasmato dall'occhio registico di Polanski.
Il risultato, come si diceva, è un oggetto multiforme, nel quale si ritrovano elementi caratterizzanti ciascuno dei passi necessari per generare la trasposizione dalla materia letteraria al film. Multiformi sono anche i significati che fuoriescono dalle profondità emotive di una “storia vera” che tale non è, o forse sì, o forse solo in parte. Dubbi irrisolvibili, incatenati nelle pieghe di un thriller la cui carta da gioco principale è l'ambiguità, tema non a caso tanto caro sia al cinema di Assayas che a quello di Polanski.
D'après une histoire vrai è, sopra a tutto, un doloroso racconto di fantasmi. Fluttuanti, lievi, feroci e misteriosi. I fantasmi di una madre internata e morta suicida la cui tragedia ispira un romanzo best seller. I fantasmi di una pagina bianca che non si riesce più a riempire in alcun modo. I fantasmi di quel “libro della vita” che si ha dentro ma non si è capaci di estrarre. I fantasmi del successo artistico, paradossalmente destinati ad acuire stanchezza, solitudine e senso di mancamento verso se stessi. Infine, i fantasmi del doppio, personificati da una donna che forse esiste o forse no; un'ammiratrice senza scrupoli, una dolce strega dagli occhioni blu che incarna purezza celestiale e crudeltà demoniaca, un alter ego che scava dentro la mente della protagonista sino a divorarne ogni certezza. Una ghost writer (fantasmi, anche qui), sospesa dietro le quinte dell'immaginazione, sopra le nuvole del proprio firmamento, nei meandri di una convulsa ricerca della propria verità.
Il rapporto tra Delphine, scrittrice in crisi d'identità e Elle (Lei nella versione italiana), sua seguace invadente e irresistibile, si situa su una strada che accosta il duello manipolatorio tra Kristen Stewart e Juliette Binoche in Sils Maria e la folle ossessione di Kathy Bates verso James Caan nel magnifico Misery di Rob Reiner. Qui, però, almeno per ampi tratti, tutto è più sfumato e misurato, tanto che il classico rapporto carnefice-vittima si perde nel fango di una profonda inconoscibilità, impossibile da decifrare, almeno sino all'approdo a una parte finale meno efficace perché troppo esibita.
Durante la visione, in molti momenti, si ha la sensazione di assistere a un film non solo scritto ma anche diretto da Assayas, più che da Polanski. La regia di quest'ultimo pare infatti nascondersi nell'ombra. Eppure, nelle sfumature e nei ritagli dell'immagine, la poetica polanskiana riesce a farsi intravedere, in conturbanti oscurità che regalano sospiri e profumi grazie ai quali la mente per un attimo vaga verso tappe della sua gloriosa carriera, dalla persecuzione autoindotta de L'inquilino del terzo piano alla flagellazione interiore di Repulsion, dalla crudeltà melliflua di Rosemary's Baby al perverso rapporto di dominio e sottomissione in Luna di fiele, fino al rimescolamento di ruoli di Venere in pelliccia.
Rimane comunque la sensazione che il grande autore ormai ottantaquattrenne abbia in questo caso voluto tenersi in disparte, lasciando il centro della scena a una duplice penna, quella della de Vigan e quella di Assayas. Duplice, appunto; dall'ambiguità al complesso tema del doppio, da una donna a due, da due a una. Un'anima per due volti, quello sofferto di Emmanuelle Seigner e quello seducente di Eva Green, la quale, pur con qualche eccesso, dimostra ancora, dopo l'ottima prova nella serie Penny Dreadful, di saper incarnare con efficacia la dicotomia angelo/diavolo.
Le due tengono la scena quasi sempre da sole, senza affanni. Si studiano e si ammirano, si cercano e si sfidano. Intorno a loro la messinscena scorre silenziosa e trattenuta, al netto di qualche improvvisa esplosione di violenza (il massacro del frullatore con il mattarello, il gesso in mille pezzi) e di piccoli squarci di ipnotico orrore (l'inquietante rana all'interno di un libro per bambini). La storia, contenitore di altre microstorie, si dipana lungo il confine liminale tra realtà e immaginazione, sino a un epilogo non del tutto soddisfacente perché troppo sfacciato, tanto da ricordare il sopracitato Misery con evidenza eccessivamente marcata. Più interessante è ciò che avviene prima, durante un processo di conoscenza altrui che poi altro non è se non un viaggio verso la (definitiva?) conoscenza di sé.
Un viaggio periglioso, scomodo, zoppicante e beffardo. Eppure necessario.
Alessio Gradogna
Sezioni di riferimento: Film al cinema, Special Roman Polanski
Scheda tecnica
Titolo originale: D'après une histoire vraie
Anno: 2017
Durata: 110'
Regia: Roman Polanski
Soggetto: dal romanzo di Delphine de Vigan
Sceneggiatura: Olivier Assayas, Roman Polanski
Fotografia: Pawel Edelman
Musiche: Alexandre Desplat
Attori: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez















































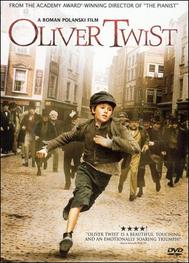



















 Feed RSS
Feed RSS
