
Where the church bells ring and strong love grows
She grew up good
She grew up slow
Like American honey.”
American Honey, Lady Antebellum
Star, diciottenne dell'Oklahoma, fa parte di quel tessuto suburbano che vegeta ai margini della società americana. Sin dalla prima inquadratura, che la immortala nell'intento di rovistare nella spazzatura in cerca di cibo per due fratellini di cui si prende cura, colpisce il pubblico per la sua esuberante spontaneità e per il volto, di straordinaria bellezza, dell'attrice esordiente Sasha Lane. Star è insomma una stella che brilla di luce propria, una creatura ribelle che mal sopporta la condizione di miserabile con la quale è costretta a convivere. Ecco perché decide di abbandonare ogni cosa e di fuggire con una combriccola sgangherata di ragazzi che incontra nel parcheggio di un supermarket Walmart.
Il gruppo, che si sposta attraverso gli Stati Uniti con un minibus per vendere riviste porta a porta, è alle dipendenze di Krystal (Riley Keough, nipote di Elvis Presley), che riscuote il denaro incassato giorno per giorno e che si occupa di trovare un luogo dove trascorrere la notte. Una prospettiva davvero poco allettante, ma che rappresenta per Star la speranza in un nuovo inizio, l'occasione per costruirsi un futuro meno squallido, che non si riduca ad accudire dei bambini mentre la loro madre prende lezioni di danza country e il padre, ubriaco, tenta di sedurla. E poi, tra i nuovi compagni d'avventura, furoreggia Jake (Shia LaBeouf), che la conquista subito, quando improvvisa all'interno del supermercato un balletto sulle note di We Found Love di Rihanna.
Con un bagaglio pieno soltanto di sogni, affamata d'amore e di voglia di vivere, Star intraprende allora un viaggio on the road che la porterà alla scoperta di se stessa e della decadenza, nemmeno tanto ben nascosta sotto il tappeto, di un'America che, mai come in questa storia, appare inesorabilmente giunta al capolinea.
Vincitore del Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes, il quarto film di Andrea Arnold, il primo girato negli USA, prende spunto da un’inchiesta del New York Times del 2007 che si occupava del fenomeno “mag crew” (ovvero il reclutamento, al limite della legalità, di adolescenti per la vendita di riviste porta a porta). In American Honey, dall'omonimo pezzo della band country Lady Antebellum, ritornano gli elementi presenti nei lavori della Arnold sin dai suoi cortometraggi d'esordio: addentrandoci nelle periferie degradate incappiamo nei disadattati che le abitano, rassegnati a un’esistenza che il luogo da dove provengono ha già stabilito, ma pure coloro che “non ci stanno”, che si ribellano a una condizione che li riduce a sub-umani e che annaspano alla ricerca di un sacrosanto riscatto. Come la giovanissima Star.
La regista inglese, camera in spalla, gira un road movie che punta su un forte coinvolgimento dello spettatore, il quale diventa parte integrante della strampalata comitiva in viaggio. È un racconto delicato quello della Arnold, anche nella narrazione delle vicende più squallide e violente. Non resta dunque che abbandonarsi alle emozioni e immergersi nei primi piani mozzafiato di Sasha Lane, merito dell'utilizzo del formato 4:3 e della bellissima fotografia di Robbie Ryan.
Senza nulla togliere alla regia, un dovuto plauso va alla debuttante interprete di Star: un personaggio con una potentissima componente empatica, che sprizza carica vitale da ogni poro della pelle, che affascina e persino seduce il pubblico. Lo stesso dicasi per gli altri protagonisti di American Honey, quasi tutti attori non professionisti senza alcuna passata esperienza cinematografica. Com'era già accaduto per Katie Jarvis (Mia) in Fish Tank, la Lane è stata notata per caso dalla Arnold e quindi scritturata. Se Mia e Star si assomigliano per freschezza, spontaneità e sfrontatezza, diventa comunque inevitabile il confronto anche con le eroine che popolano i lavori di Céline Sciamma. Ma i paragoni non si fermano qui. Come infatti non riscontrare delle analogie tra i giovani, tossici e alcolizzati, venditori porta a porta di American Honey con i personaggi che si incontrano nelle opere di Larry Clark, Gregg Araki e Harmony Korine?
Al cast principale si aggiunge il campionario di rara bestialità umana che Star e compagni incrociano lungo il loro cammino: ricchi cowboys vecchi e arrapati, ragazzine poco più che decenni che si atteggiano a prostitute, mamme drogate, operai che non si fanno scrupoli a chiedere un rapporto sessuale a un'adolescente. E il paesaggio, elemento fondamentale del road movie, contribuisce a mostrare tutta la sporcizia che si cela dietro le casette a schiera, già di per sé desolanti, della middle class. Attraverso i finestrini del minibus scorrono immagini di silos, parcheggi con giganteschi tir, complessi industriali, impianti petroliferi, centri commerciali e fast food.
Tra tanto degrado, soltanto Star conserva un rapporto privilegiato con la natura. Quando si stende con Jake su un prato oppure quando un orso le si avvicina o, ancora, quando il vento le soffia tra i capelli, l'ambiente che la circonda diventa improvvisamente magico. E riesce addirittura a concedersi un tocco di poesia nei momenti in cui la bassezza morale sfiora il limite del sopportabile. Splendida la scena che vede un terzetto di vecchi cowboys vestiti di bianco dalla testa ai piedi (cappello compreso) abbordare la ragazza per poi condurla in una villa lussuosa di proprietà di uno dei tre. Mentre le offrono birra e la incitano a ingurgitare del mescal, verme compreso, lei si preoccupa di un insetto che sta annegando in piscina e lo salva.
Tuttavia, anche se Star ha le carte in regola per intravedere la luce in fondo al tunnel (o almeno lotterà per aggrapparsi a un'ancora di salvezza), il destino non appare certo roseo. Esiste il rischio, infatti, di far ritorno al punto di partenza. Emblematico, sotto quest'ultimo aspetto, l'incontro con due bambini che vivono con la madre tossica: dapprima li aiuta portando loro la spesa, ma poi li abbandona a se stessi, spaventata dal circolo vizioso in cui stava cadendo.
Quali sorprese riserverà il futuro a Star? Forse, nella migliore delle ipotesi, si accontenterà di trovare l'amore in a hopeless place, come canta Rihanna. Ma vada come vada, quel che emerge dal film della Arnold è che il famigerato American dream non abita più nella putrescente suburbia degli USA.
Serena Casagrande
Sezioni di riferimento: America Oggi, Cannes 69
Scheda tecnica
Titolo originale: American Honey
Anno: 2016
Regia: Andrea Arnold
Sceneggiatura: Andrea Arnold
Fotografia: Robbie Ryan
Montaggio: Joe Bini
Colonna sonora: AA. VV.
Durata: 163'
Attori: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, McCaul Lombardi, Arielle Holmes














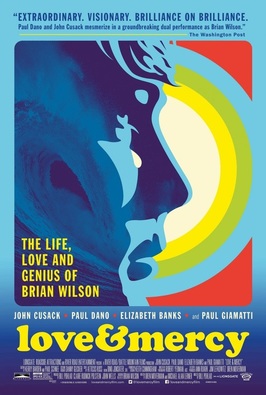





























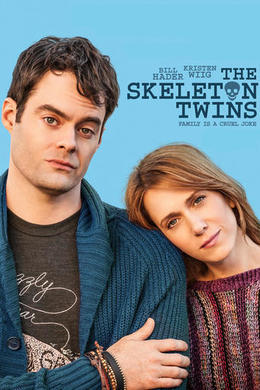















 Feed RSS
Feed RSS
