
Un giorno Meira, per puro caso, incontra Félix, uomo che nulla a che fare con la comunità e che vive un momento di conflitto e dolore interiore, avendo appena perso il padre, con cui non ha fatto in tempo a risolvere conflitti sedimentati nel tempo. Tra i due, in apparenza così lontani e così diversi, scocca la classica scintilla che potrebbe cambiare il corso delle rispettive esistenze. Félix e Meira si guardano, si sfiorano, si pensano, si annusano, si cercano, anche se l'avvicinamento è assai complicato, soprattutto per le infinite remore psicologiche che frenano la donna in ogni minimo gesto. L'inseguimento procede dunque cauto, a piccole tappe, fino a che la voglia di uscire dalla gabbia in cui si è da troppo tempo confinati avrà la meglio.
Il regista canadese Maxime Giroux torna in concorso al Torino Film Festival, dove nel 2008 aveva presentato il suo lungometraggio d'esordio Demain, proponendo questa volta un'opera che ha saputo mettere d'accordo buona parte del pubblico e della critica, in virtù di una messinscena lieve, intima, graduale e attenta a sviluppare la trama contrapponendo il rigidissimo contesto sociale di appartenenza alla forza dirompente e un po' folle dell'amore.
Félix et Meira è un melodramma al contempo sussurrato e bruciante, un gioco di seduzione che vive di imbarazzi e remore, voglia di volare e ali tarpate, ideologie idiote e sogni di fuga, senso di possesso e orizzonti lontani. Il film indugia con buona efficacia sulle abitudini della comunità chassidica, alternando queste ultime alla precisa caratterizzazione di una donna (rappresentata dal volto soave di Anne-Élisabeth Bossé) che ne fa parte pur covando in sé una mentalità totalmente diversa, così da delineare la dicotomia tra le leggi inalienabili della dottrina religiosa e l'idea di emancipazione, tra i dogmi soffocanti della Fede e il romanticismo quasi infantile del sentimento nuovo che nasce, cresce e infine taglia i nodi della prigione interiore per esplodere in tutto il suo calore.
Di per sé la storia raccontata da Giroux non brilla per originalità, ma la forza del film risiede proprio nella levità con cui il rapporto sulla carta impossibile tra i protagonisti trova la strada per emergere, scartare gli ostacoli e superare gli arcaici muri del dovere abbracciando l'emozione di una vita (anzi, due) che forse può finalmente rincominciare; per portare a termine il suo compito il canadese si concentra su dettagli decisivi, tremori fanciulleschi, sguardi bassi, desideri palpitanti, tenerissime “prime volte” (i jeans, mai indossati fino ad allora), inciampando in un paio di sottolineature eccessive e inutili (il topo in trappola, i due amanti spiati dalla strada) ma rialzandosi subito grazie all'indubbia qualità di una regia tanto misurata quanto efficace.
La parte finale di Félix et Meira, accattivante per sviluppo e concretezza e giustamente aperta fino all'ultima inquadratura e oltre, incontra la migliore via per una risoluzione in cui si fondono insieme malinconia e speranza, perdita e successo, rimpianto e consapevolezza, delineando l'eterna verità per la quale, volenti o nolenti, bisogna imparare a lasciar andare la persona che si ama, regalandole un ultimo ma fondamentale gesto di affetto e rispetto: la libertà.
Anche perché poi, dopotutto, si fa sempre in tempo a tornare indietro.
Alessio Gradogna
Sezione di riferimento: Torino 32
Scheda tecnica
Titolo originale: Félix et Meira
Anno: 2014
Regia: Maxime Giroux
Sceneggiatura: Alexandre Laferrière, Maxime Giroux
Fotografia: Sara Mishara
Montaggio: Mathieu Bouchard-Malo
Attori: Anne-Élisabeth Bossé, Benoit Girard, Hadas Yaron, Josh Dolgin, Luzer Twersky
Musiche: Olivier Alary
Durata: 102'
























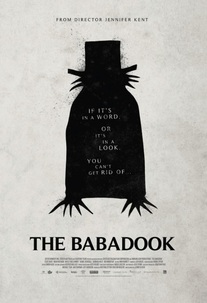


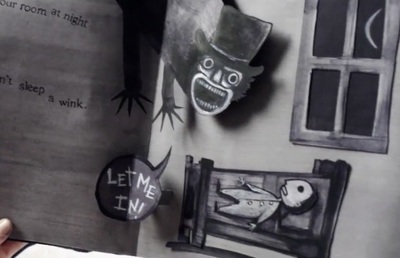

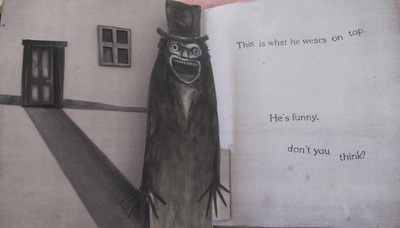

















 Feed RSS
Feed RSS
