
The Guilty, candidato all’Oscar per la Danimarca e debutto nel lungometraggio del regista classe 1988 Gustav Möller, è stato presentato in anteprima nazionale in concorso al Torino Film Festival, dove ha messo d’accordo tutti, critici e spettatori, portandosi a casa il premio della giuria per la miglior sceneggiatura, il premio come miglior attore al protagonista Jakob Cedergren (ex-aequo con l’ottimo Rainer Bock del noir tedesco Atlas) e il premio del pubblico (pari merito con il bellissimo Nos Batailles di Guillaume Senez). Riconoscimenti meritati, per un’opera che riesce a ridefinire il concetto cinematografico del non-visto, ponendo in essere il trionfo assoluto del fuori campo, inteso come insieme di eventi che si svolgono lontano dall’occhio diretto dell’avventore.
La Settima Arte, sin dalle sue origini, si è sempre imposta come valvola di sfogo con cui mostrare, raccontare, fotografare la/una realtà. Intorno ad essa, però, non ha mai smesso di seguire un percorso parallelo atto a cavalcare l’immaginazione del fruitore, attraverso una serie infinita di indizi, suggerimenti, tracce, orme e suggestioni abili a costruire nella mente la visualizzazione anche di ciò che l’obiettivo lascia ai margini, invisibile ma presente, indicato ma nascosto, palpitante ma silente. In questo senso, The Guilty supera brillantemente le convenzioni, tramutandoci in specchi riflettenti di una narrazione, quella che si svolge fuori dal campo visivo, inquietante e coinvolgente.
Nell’arco della sua limitata durata il lavoro di Möller, tratto dalla registrazione audio di una vera chiamata di soccorso arrivata al 911, ci ingloba in un universo tanto ristretto quanto illimitato. Tutto il film si dipana tra poche fredde mura, ma i fatti decisivi deflagrano fuori, per le strade, in un altrove che costruiamo con la mente senza poterlo vedere, senza poterlo decodificare, senza poterci entrare. Noi siamo imprigionati lì con Asger Holm e i suoi colleghi (presenti ma ridotti a figurine di sfondo); siamo topi in una scatola, a mordere la tensione indossando e togliendo convulsamente quella cuffia, a comporre un numero dopo l’altro per unire le tessere di un cruciverba dalla difficile soluzione, a sentir fermare il fiato negli attimi in cui ogni illusione vincente pare perduta.
Girata in pochi giorni, con l’ausilio di sole 3 telecamere, la pellicola danese ricorda in parte alcuni recenti one man show (ad esempio Locke di Steven Knight), ribaltando però il senso del discorso: qui non è il personaggio a lottare per la vita. Egli invece si trova suo malgrado responsabile della vita di qualcun altro; è un oracolo senza fede, reo di colpe non ancora espiate e lasciate anch’esse fuori campo. Nel tentativo di salvare questa donna sconosciuta c’è la sua redenzione, un tentativo di ritrovare la pace interiore smarrita, una missione pregna di umanità ed empatia ma anche di amor proprio. Il nostro giudizio nei suoi confronti peraltro non esiste, perché non ce n’è il tempo: i secondi scorrono veloci, la fibrillazione sale, la frustrazione pugnala, la speranza fluttua.
The Guilty è un oggetto filmico che sorprende e appassiona, va dritto per la sua strada e non conosce deviazioni o comodi sentieri alternativi. Ci si ambienta per pochi istanti, poi squilla il telefono e una voce rotta di donna chiede aiuto. Da quell’istante si entra in una bolla e non se esce più. La finzione si nasconde, il realismo stringe le sue ali. Fuori da quelle due stanze c’è il dramma. Fuori dalla sala cinematografica non esiste nulla. Almeno per 80 minuti. Si chiudono le porte, il treno scatta, inizia la sua corsa e non si ferma. Fino all’ultimo sbuffo. Fino all’ultimo respiro.
Alessio Gradogna
Sezioni di riferimento: Eurocinema, Torino Film Festival
Scheda tecnica
Titolo originale: Den Skyldige
Regia: Gustav Möller
Sceneggiatura: Emil Nygaard Albertsen, Gustav Möller
Fotografia: Jasper J. Spanning
Attori: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen
Anno: 2018
Durata: 85’














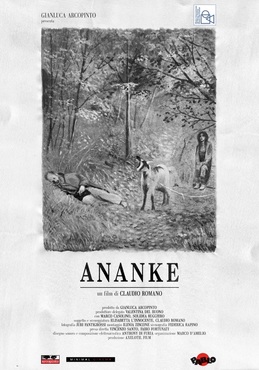














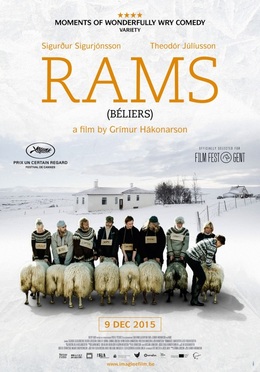








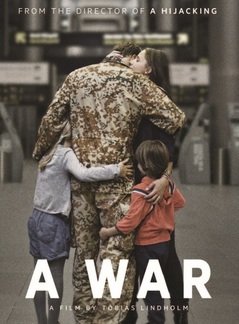





















 Feed RSS
Feed RSS
